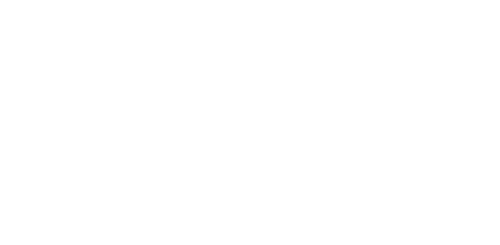Franco Marescotti vide la luce a Pesaro il 10 gennaio 1908, nato dall'unione di Pietro e Rosa Badioli. Il padre, di radici piemontesi, gestiva con abilità imprenditoriale una florida fabbrica dolciaria di proprietà della moglie. Ma ancor più, Pietro Marescotti mostrava uno spiccato interesse per la politica e si era avvicinato al partito socialista pesarese che all’epoca era in una fase di nuovo sviluppo organizzativo grazie all’instancabile attivismo dell’allora giovane avvocato ed esponente Giuseppe Filippini.
Franco e la sorella minore Nunzia trascorsero un’infanzia tranquilla, in una famiglia della media borghesia di provincia, che non ebbe a soffrire dei traumi del primo conflitto mondiale, né del successivo arrivo al potere di Benito Mussolini, almeno nei suoi anni iniziali.
Poco incline agli studi classici e solo parzialmente a quelli scientifici, il giovane Marescotti aveva dimostrato una buona attitudine per il disegno a mano libera, anche se quella passione non trovava alcun riscontro adeguato nel suo percorso scolastico. Invece, con il riordino dell’istruzione agraria nel regno, la scuola pratica di agricoltura, che a Pesaro aveva una storia già ben consolidata, fu nel 1923 elevata al grado di scuola professionale secondaria. La riorganizzazione del curriculum comprendeva materie di economia rurale, ma anche di chimica agraria, tecnologia, disegno e costruzione, aspetti tecnico-gestionali che certamente dovevano essere apparsi al giovane Marescotti più affini ai suoi interessi. Nel luglio del 1927 egli otteneva, dunque, il diploma di perito agrario presso la scuola ospitata nella cinquecentesca villa di Caprile.
La Pesaro degli anni di passaggio fra il diciannovesimo e il ventesimo secolo era una città colta e vivace, che si era guadagnata un’eco nazionale, specialmente in campo musicale. Infatti, alla morte del maestro Gioacchino Rossini, questi aveva lasciato alla città un cospicuo patrimonio che aveva permesso, ad esempio, l’apertura dell’omonimo Conservatorio, dove nei primissimi anni del Novecento era stato chiamato alla direzione il compositore Amilcare Zanella. Questi, mentre aveva ridato lustro al repertorio rossiniano, si era mostrato molto aperto alle sperimentazioni più moderne, come quelle elaborate dalla contemporanea scuola di Vienna. La musica rimase più che un semplice diletto per Franco Marescotti; quella, nelle sue declinazioni più vitali e ricche di colore, continuò a suscitare la sua curiosità e un indubbio interesse fino agli ultimi anni della sua vita.
Ma quell’atmosfera di dolce vita di provincia non bastò a tenere la famiglia Marescotti lontana dalla crisi economica nazionale che colpì le piccole imprese artigiane alla fine degli anni Venti, né dai rapidi cambiamenti che subiva la politica del regime al punto da obbligare Pietro Marescotti ad allontanarsi da Pesaro, dove evidentemente si era troppo esposto a fianco dei socialisti locali. Conseguenza ne fu che nel 1929 i Marescotti si trasferirono a Roma; andarono ad abitare nel quartiere di Tor Sapienza, nella prima periferia orientale della capitale, dove era forte la componente operaia e antifascista.
Il giovane Franco non rimase a lungo inoperoso: un suo disegno capitato nelle mani di uno dei collaboratori dello studio di Armando Brasini (1879-1965), da poco nominato da Mussolini Accademico d’Italia, gli procurò il primo lavoro della sua breve stagione romana. La collaborazione durò circa quattro anni: un tirocinio importante, ma pieno di contraddizioni. La cultura architettonica romana, bigotta e culturalmente conformista, mostrava chiaramente le sue preferenze per un «eclettismo che amava il colossale».
Lo studio di Brasini era fra quelli più attivi nella capitale; all'Accademico d'Italia non mancavano i committenti; furono quelli gli anni in cui si progettò il complesso del Buon Pastore (1929-33), mentre si realizzava la Basilica del Cuore Immacolato di Maria e l’adiacente ponte Flaminio, e in cui partecipò al concorso internazionale per il Palazzo dei Soviet a Mosca (1931), su pressione diretta da parte del Duce.
Una più che palese ostilità di Marescotti verso lo stile bombastico e autoritario che le architetture di Brasini ostentavano, costringevano il pesarese a mordere il freno.
Viceversa, si ritrovava spesso con un gruppo di amici al Caffè Rosati, in piazza del Popolo, che avevano dato vita a un cenacolo; in occasione di quegli appuntamenti non era raro incontrare artisti, alcuni provenienti dalla vicina Accademia delle Belle Arti, così come letterati, musicisti e musicologi data la prossimità del Liceo Musicale di Santa Cecilia, e personaggi dello spettacolo. Sovente Marescotti portava con sé le sue tempere: prospettive ben costruite, a cui i colori pastello regalavano un’aura di sospesa serenità e in cui, pur se ancora timidamente, si manifestava la sua ricerca dello spirito del moderno. L'edificio alto, a piani sfalsati, che appare nel primo disegno prospettico della «casa dell'uomo» era lontano anni luce dalle architetture monumentali con cui si confrontava quotidianamente.
L’incontro con il coetaneo Irenio Diotallevi (1909-1954), che avvenne alla fine del 1932, rappresentò un momento di svolta nella strada verso l’architettura moderna che Marescotti intendeva intraprendere. Il primo, iscritto alla Scuola di Ingegneria a San Pietro in Vincoli, era in procinto di completare il suo progetto di laurea; si trattava di un albergo moderno, pensato come un blocco multipiano, ad andamento orizzontale, semplice e sobrio nelle forme, ma che presentava alcuni dettagli che suggerivano l’apertura verso nuovi linguaggi architettonici. Marescotti in uno slancio di generosità ma anche di emulazione si propose di aiutarlo. Cominciò in quel momento un’amicizia e una collaborazione professionale che si sarebbero concluse almeno due decenni più tardi.
Per Marescotti era arrivato il momento di abbandonare il ruolo di disegnatore presso l’ufficio di Brasini. Mentre Diotallevi intraprendeva un viaggio post-laurea in quella che ancora per pochissimo tempo era la tedesca Repubblica di Weimar, l’altro ebbe l’occasione di collaborare con l’ingegnere e poi celebre scenografo Guido Fiorini (1891-1965), che dalla fine degli anni Venti si era dedicato allo studio dei primi grattacieli parzialmente realizzati con struttura metallica, a cui era stato dato il nome di ‘tensistruttura’, che aveva anche brevettato.
Pur se temporanea, l’esperienza a fianco di Fiorini aveva regalato a Marescotti una boccata di ossigeno, al pari del momento di crescita intellettuale vissuto al rientro dalla Germania di Diotallevi. L’ingegnere aveva portato con sé alcune copie delle riviste di architettura moderna più affermate, come Moderne Bauformen e Baumeister, ma anche i volumi della serie dei Bauhausbücher, fra cui Internationale Architektur (1925) di Walter Gropius, i testi chiave di Ludwig Hilberseimer, Groszstadtarchitektur (1927) e Beton als Gestalter (1928), per citare due fra i più influenti, e documenti relativi agli studi di Aleksandr Klein sull’alloggio minimo standardizzato (1927-28). Nei successivi studi e pubblicazioni di Marescotti la letteratura tedesca, che aveva aperto la strada al razionalismo moderno e all’architettura funzionale, non cessò di avere un ruolo di primo piano.
Intanto, nel 1934, quando Fiorini venne invitato a realizzare un'aviorimessa in ossatura metallica a Milano, anche Marescotti sentì il forte richiamo della capitale lombarda. Da un lato lo attraevano le reinvenzioni neoclassiche del Novecento milanese, per quanto romantiche; dall'altro furono soprattutto lo spirito moderno della città e i primi passi di un razionalismo italiano – ignorato e osteggiato a Roma – a spingerlo verso il nord. Dopo un breve passaggio a Genova, città da cui avrebbe potuto più facilmente espatriare (come pensò di fare per qualche tempo), Marescotti si trasferì a Pavia e poco dopo giunse a Milano.
Non sorprende che il suo primo contatto a Milano fosse lo studio di Luciano Baldessari (1896-1982), che all'epoca aveva già raggiunto una certa notorietà come scenografo. È plausibile che l'indirizzo in via Santa Marta gli fosse stato fornito proprio da Fiorini, prima che le loro strade si separassero. Seguendo un rituale ormai consolidato, si presentò con il suo portfolio; forse parlarono degli anni che Baldessari aveva trascorso a Berlino, ma sicuramente gli interessi di Marescotti per la standardizzazione e la prefabbricazione convinsero Baldessari che il contatto più fertile potesse essere con l'architetto Giuseppe Pogatschnig Pagano (1896-1945), all'epoca impegnato nella preparazione della “Mostra dei Materiali Edilizi e Costruttivi” alla VI Triennale milanese del 1936 e che era alla ricerca di giovani assistenti.
Con Pagano l'intesa nacque istantaneamente e la collaborazione divenne presto molto attiva. Inizialmente Marescotti, insieme all'amico Diotallevi che l'aveva raggiunto a Milano, fu assunto nell'ufficio tecnico della Triennale; successivamente avviò la sua partecipazione alla redazione di «Casabella», la rivista di cui Pagano fu il carismatico direttore dal 1930 al 1943.
Fu in quel contesto, e con il probabile contributo del fedele Diotallevi, che il pesarese incontrò Ines Tonin, meglio nota come Rosabella, che sposò nel gennaio del 1936.
Senza interruzioni, dal 1937 al 1943, "Casabella" divenne per Marescotti "una casa come lui": una casa sana, "meno retorica", ma soprattutto espressione della moralità – intesa come chiarezza, onestà, rettitudine ed educazione – che il direttore richiedeva agli architetti in un periodo in cui i riflettori sulle architetture del regime avevano reso le polemiche particolarmente accese.
Per Marescotti quello fu un periodo di studio e impegno culturale molto intenso, in cui si espressero con efficacia i temi originali della sua ricerca, primo fra tutti la “casa popolare”, alla cui analisi sono dedicati i numeri monografici 162, 163 e 164 di "Casabella". Quegli studi costituirono un vero e proprio inventario dei metodi e dei modi di costruzione dell'abitazione a basso costo; le fonti originali della ricerca, selezionate, catalogate e ridisegnate, furono raccolte nel volume Il problema sociale, costruttivo ed economico dell'abitazione, preparato da Marescotti con Diotallevi e pubblicato successivamente nel 1948. Raccolti in schede identificate da un codice colore che segnalava il passaggio fra le sezioni – una parte iniziale di inquadramento storico del tema seguita da approfondimenti tipologici, costruttivi e di design domestico – questi studi rappresentarono il punto di partenza per l'elaborazione di un "manuale" dei tipi edilizi per la progettazione della casa economica e popolare, cui Diotallevi e Marescotti intendevano dare in seguito uno sviluppo ancora maggiore.
Negli anni della collaborazione a "Casabella", alle ricerche sui tipi edilizi si affiancarono gli studi sulla standardizzazione degli elementi costruttivi e sulla prefabbricazione. Si trattava di un campo di studio che trovò nella rivista – che dal 1938 aggiunse al suo titolo storico la parola "Costruzioni" per sottolineare l'importanza attribuita al sapere tecnico – uno spazio di primo piano, come evidenziato dai numerosi articoli su temi relativi a materiali e tecnologie, e dalle “Tavole dei Particolari Costruttivi d'Architettura”, pubblicate durante il biennio 1942-43, che rappresentavano la più diretta testimonianza degli obiettivi pedagogici che Diotallevi e Marescotti assegnavano al loro impegno professionale.
A guerra finita, il 1945 segnò un profondo cambiamento nella vita di Marescotti, che si pose l'obiettivo di affrontare un momento di verifica delle proprie posizioni culturali e politiche. Iniziò allora un periodo di febbrile attività e propaganda politica, incentrato su temi come la ricostruzione del paese, il diritto alla casa e la costruzione del nuovo nell'ambito dell'edilizia storica. In molte occasioni, era il ruolo stesso del progettista ad essere sottoposto a dure critiche. Marescotti partecipò a conferenze e dibattiti in numerose città del nord appena liberato – Milano, Torino, Genova, Reggio Emilia, Modena, per citarne alcune – presso Case della Cultura, Case del Popolo, musei e sedi di cooperative.
In quello stesso anno fu tra i fondatori del MSA – Movimento Studi di Architettura – costituito a Milano per iniziativa di un gruppo di architetti, alcuni dei quali avevano già partecipato con Pagano, dalle pagine di "Casabella", alla battaglia per l'architettura moderna e che spesso si erano ritrovati nell'impegno contro la speculazione e il saccheggio delle città, come nel caso di Piero Bottoni, per offrire una risposta concreta ai bisogni delle classi più povere.
Dal 1945 al 1947 Marescotti fu inoltre membro del Comitato Direttivo e Ordinatore del Congresso Nazionale per la Ricostruzione Edilizia e della Commissione Industrializzazione alla "Mostra Internazionale di Edilizia e della Ricostruzione" di Torino. Furono anni in cui l'impegno politico, predominante rispetto all'intervento diretto, riuscì a dare un impulso nuovo alla sua generosa partecipazione alla ricostruzione.
Marescotti lavorò alacremente al Piano del Lavoro che la C.G.I.L. stava elaborando; alla Conferenza Economica Nazionale, svoltasi a Roma nel febbraio del 1950, fu relatore per la sezione riguardante i "Problemi dell'abitazione". Nella sua relazione, che includeva un'analisi esaustiva dei dati relativi al deficit degli alloggi secondo una lettura socio-marxiana che riprendeva aspetti trattati da Friedrich Engels nel suo La situazione della classe operaia in Inghilterra (1845), esponeva con precisione il legame esistente tra fabbisogno abitativo e lotta alla disoccupazione. Quella relazione divenne il cuore della proposta inserita nel "piano economico costruttivo" diffuso dalla confederazione sindacale comunista, che si impose come una risposta, in termini politici, ai problemi economici già affrontati dal Piano Fanfani e dal programma della ricostruzione Inacasa, pubblicati nel 1949.
La collaborazione al Piano del Lavoro segnò la fine del sodalizio fra Marescotti e Diotallevi, che nel 1948 era passato alla vicepresidenza dello IACP di Milano. L’intenso periodo milanese, in cui era cresciuto e si era consolidato il legame fra i due uomini, fu anche scandito dalla loro partecipazione a tre esposizioni presso la Triennale: nel 1936, nel 1940 ("Mostra internazionale della produzione in serie") e nel 1947, con due sezioni della "Mostra sull'abitazione". Questo percorso culminò nel 1951, con il conferimento al solo Marescotti del Gran Premio della Triennale.
Diversamente da Diotallevi, Marescotti aveva scelto la strada "scomoda" dell'architetto militante, radicato nella realtà sociale in cui si trovava ad operare.
Nel 1951 ebbe inizio la progettazione del Grandi e Bertacchi, il primo dei Centri Sociali Cooperativi, completata nel 1953. Il progetto affrontava un tema scottante, quello del rapporto residenza-servizi collettivi, e prevedeva che fossero gli utenti stessi a discutere e guidare la realizzazione del progetto – un esperimento anticipatore di un'idea di partecipazione che ottenne grandi consensi insieme a critiche feroci.
Il Grandi e Bertacchi segnò, inoltre, il distacco da quella parte elitaria e borghese della cultura architettonica milanese che aveva accolto Marescotti a metà degli anni Trenta, e l'avvio di una fase della ricerca e delle attività progettuali più legata ai nuovi soggetti sociali emergenti e all'esperienza delle cooperative.
A partire dai primi anni Cinquanta, l'impegno nella progettazione delle cooperative di abitazione e di produzione e le esperienze dei Centri Sociali Cooperativi proseguirono fino alla fine degli anni '50. Al Grandi e Bertacchi seguirono il centro di Lampugnano a Milano Trezzo (1951-58), quello di Novate Milanese (1955-56) e quello di Bresso (1958).
Nel 1958 Marescotti fondava lo Studio Sociale di Architettura, a cui invitò a collaborare Giuliano Rizzi, che aveva partecipato al Collettivo di Architettura nato come estensione della cellula comunista costituitasi presso la facoltà nel 1949. I due condivisero la progettazione di numerosi progetti residenziali nell'area milanese, ma anche a Roma e nell'hinterland laziale, e nella cittadina barocca di Lentini, situata nella piana di Catania.
Nel frattempo, Marescotti si era trasferito a Roma in seguito alla vittoria nel concorso come libero docente di composizione architettonica, per il quale era stato chiamato a insegnare a Firenze, prima di ricevere, nel 1971, il trasferimento presso l'Istituto di Architettura e Urbanistica della Facoltà di Ingegneria di Catania.
Fu allora che Franco e sua moglie Rosabella scelsero di andare a vivere sulle pendici dell'Etna, in una idilliaca "casa dell'uomo" immersa in un aranceto. Gli anni dell'insegnamento, fino al pensionamento nel 1978, non limitarono la sua personalissima ricerca, gli studi sui sistemi associativi degli alloggi, sulla prefabbricazione degli elementi strutturali e sull'ideale della casa “per uno e per infiniti uomini.”
Quando se ne andò il 12 giugno del 1991 nella sua casa a San Gregorio di Catania, circondato dai profumi di quella natura che gli era stata amica, fra mare e conchiglie, fiori e frutti dai sapori antichi, e il dolce sorriso di Rosabella, si era finalmente compiuta una vita vissuta intensamente, nel corpo come nella mente.
[Maristella Casciato]